Cosa indossavi? Le parole nei processi penali per violenza di genere

Mi sono imbattuta per caso e di corsa su questo titolo di libro: “Cosa indossavi?”
Ci sono parole, frasi, argomenti e foto che ci fanno fermare nel nostro scroll continuo sui social e “Cosa indossavi?” mi ha fatto fermare.
Una eco di voci inquisitorie, una donna a capo chino: ecco la scena che mi si è subito affacciata alla mente. La vittima, chiaramente, di una molestia o peggio di una violenza che si sente chiedere cosa indossava, perché è colpa sua se è stata molestata.
Le parole sono importanti. Le parole ci rappresentano, rappresentano il nostro io, usiamo le parole per rappresentarci nel mondo.
Per questo motivo “Cosa indossavi?” ha pesato moltissimo, sui miei occhi senza requie.
E con curiosità ho scoperto che l’autore di questo libro non ha tono accusatorio, anzi, è dalla nostra parte, dalla parte delle donne, degli uomini, delle vittime, dei cittadini tutti e lo è dal pulpito giusto: Iacopo Benevieri, avvocato penalista, si occupa del linguaggio come strumento di attuazione dei diritti e di esercizio dei poteri nel processo, argomento di cui scrive in riviste giuridiche e che tratta come relatore in convegni e corsi di aggiornamento professionale. Dal 2019 è responsabile della Commissione sulla Linguistica Giudiziaria della Camera Penale di Roma ed è fondatore del blog e del gruppo Facebook “Giustizia A Parole”.

Avvocato ben trovato, che libro è “Cosa indossavi? Le parole nei processi penali per violenza di genere” e a chi è rivolto?
Il libro vuole essere una lente di ingrandimento. Vuole essere uno strumento per osservare nel dettaglio qualcosa che accade quotidianamente sotto i nostri occhi ma che ci sfugge: l’uso del linguaggio come strumento di potere, spesso di prepotenza, nei confronti di chi è portatore di vulnerabilità. Spesso questo uso, anzi questo abuso dello strumento linguistico entra anche nei luoghi istituzionali, come le aule di Giustizia, dove per esempio la persona vittima di violenza può subire domande e valutazioni degradanti, come quella che ha ispirato il titolo del libro. In questi casi il linguaggio esprime sempre una subcultura maschiocentrica, ormai durevolmente iscritta nei gesti, nei toni, nel lessico. Così le parole pronunciate in tribunale, anziché essere strumento di diritti e di garanzie, divengono un dispositivo di dominio, per giunta nel “nome del popolo italiano”. Il mio lavoro dunque si occupa di “ingrandire” quei sottili meccanismi linguistici, spesso invisibili, attraverso i quali questo potere degradante può essere attuato senza che ce ne accorgiamo. Ecco perché il libro si rivolge a tutti: docenti, giornaliste e giornalisti, operatrici e operatori del diritto, personale impiegato nell’assistenza sociale, cittadine e cittadini. Tutti siamo chiamati a usare responsabilmente il linguaggio, soprattutto quando ci relazioniamo per vari motivi con chi porta su di sé una qualsiasi vulnerabilità: psichica, fisica, sociale, etnica, economica, di genere. Sono convinto che nell’uso del linguaggio non operi la presunzione di innocenza, che invece opera nei processi penali: fuor di metafora, voglio dire che non siamo mai linguisticamente innocenti, ma siamo sempre linguisticamente colpevoli, cioè responsabili di ciò che produciamo e diffondiamo con le parole.
“Cosa indossavi?” come è nato?
Il libro è nato dalla mia esperienza professionale in aula. Ascoltando le domande che venivano rivolte alle vittime di violenza, le tecniche di esame e interrogatorio, anche nell’uso del silenzio e delle pause, ho avvertito come spesso il linguaggio introduceva stereotipi sessisti. Formulare a una donna la domanda se all’inizio della serata in discoteca fosse attratta dalla persona che poi l’ha violentata significa usare un linguaggio che introduce pregiudizi e non offre garanzie, né contribuisce all’accertamento del fatto. Significa usare un linguaggio che riproduce e rinforza un potere simbolico androcentrico. Ho avvertito in sostanza che non solo nella società, ma anche nell’aula di udienza non c’è sufficiente consapevolezza dell’importanza e della delicatezza dello strumento linguistico. Ho voluto gettare un sasso nello stagno immobile della riflessione su questo tema.
Secondo lei, Avvocato, è possibile compiere una rivoluzione culturale cominciando dalle parole?
Non può essere diversamente. Il linguaggio ha continue ricadute nella realtà umana. Qualsiasi nuova consapevolezza non può che originarsi attraverso un mutamento nel linguaggio. Le parole non servono solo a esprimersi, ma soprattutto a interpretare il mondo, a comprendere sé stessi e a progettare un futuro. Tutti siamo responsabili del nostro linguaggio. Ogni volta decidiamo se usare il linguaggio del dominio oppure il linguaggio delle garanzie. Se usare il linguaggio che esclude, che ghettizza e degrada, oppure, al contrario, un linguaggio che include, che garantisce l’altro, che determina l’incontro e non la separazione, che sia “comunicazione” nel senso etimologico di mettersi in comunione con il prossimo. Ciascuno di noi è chiamato ad attuare l’art. 4 comma 2 della Costituzione, che ci invita a svolgere un’attività professionale o una funzione con uno scopo comune: quello di concorrere al progresso non solo materiale, ma anche spirituale della società. Ecco lo strumento del linguaggio è centrale nell’attuazione di questo progresso e a ciascuno, nessuno escluso, la Costituzione repubblicana assegna questo compito.
Che cosa è il gruppo da lei fondato “Giustizia a parole”?
È uno spazio virtuale da me creato, presente sia come gruppo su Facebook che come blog “giustiziaparole.com“, nel quale raccolgo riflessioni e iniziative, sia editoriali, giornalistiche e formative, che abbiano al centro l’uso del linguaggio nella Giustizia, nel diritto e nel processo penale. La Giustizia è fatta di parole. Quando l’uomo anticamente abbandonò la vendetta privata e la faida familiare e delegò la risoluzione dei conflitti sociali alle parole, cioè alla narrazione dei fatti davanti a un giudice, attuò una straordinaria rivoluzione. Ecco, questa rivoluzione dobbiamo difenderla e proteggerla, perché assistiamo attualmente al ritorno nello spazio sacro del diritto di un linguaggio primitivo e di dominio.
Qual è il primo ricordo che ha sul “peso” delle parole? Di lei personalmente e poi di lei avvocato.
Personalmente il primo ricordo è legato all’adolescenza, quando scoprii in casa il vocabolario dei sinonimi. Fu come osservare una tavolozza di mille colori, rimasi incantato dalle sfumature cromatiche che la nostra lingua offriva. Come avvocato penalista, invece, la prima riflessione sulle parole è iniziata un giorno quando mi trovai in aula di udienza e fu interrogata una ragazza portatrice di deficit linguistico-cognitivi. Nessuno nell’aula aveva la capacità di adeguare il proprio linguaggio a quella persona e, pertanto, le risposte che costei forniva erano spesso imprecise e frutto di una errata comprensione delle domande. Era evidente che le parole davano forma e sostanza alla Giustizia e dell’uso delle parole dovevamo occuparcene con urgenza.
Quale è stato il suo cammino?
Mi sono laureato a Firenze in procedura penale e mi sono trasferito a Roma. Nel corso di questi 20 anni ho esercitato la professione di avvocato penalista cercando di studiare l’aspetto linguistico della professione: dall’incontro con il cliente, all’aula di udienza, alla redazione di atti difensivi. A novembre del 2019 all’interno della Camera Penale di Roma abbiamo costituito la Commissione sulla Linguistica Giudiziaria, l’unica in Italia, di cui sono responsabile, che si occupa di studiare gli aspetti linguistici del processo penale e di organizzare eventi formativi e di studio su questo tema. Quasi un anno dopo abbiamo pubblicato il Manifesto sulla linguistica giudiziaria, che sintetizza obiettivi e spirito delle nostre riflessioni. Negli ultimi anni mi sono dedicato anche alla formazione professionale in convegni e seminari sul ruolo del linguaggio nella professione legale.
Quali progetti ha in cantiere?
Sto scrivendo altri due libri sul tema del linguaggio, osservato da prospettive diverse anche se la finalità è quella di continuare a esplorare il linguaggio nelle sue due dimensioni: come momento di esercizio del potere e come strumento di attuazione dei diritti. Come avvocato e come cittadino mi ispiro alla grande lezione di Tullio De Mauro e credo fermamente che il linguaggio debba tornare a essere strumento democratico di accesso ai diritti nelle mani di ciascuno di noi.
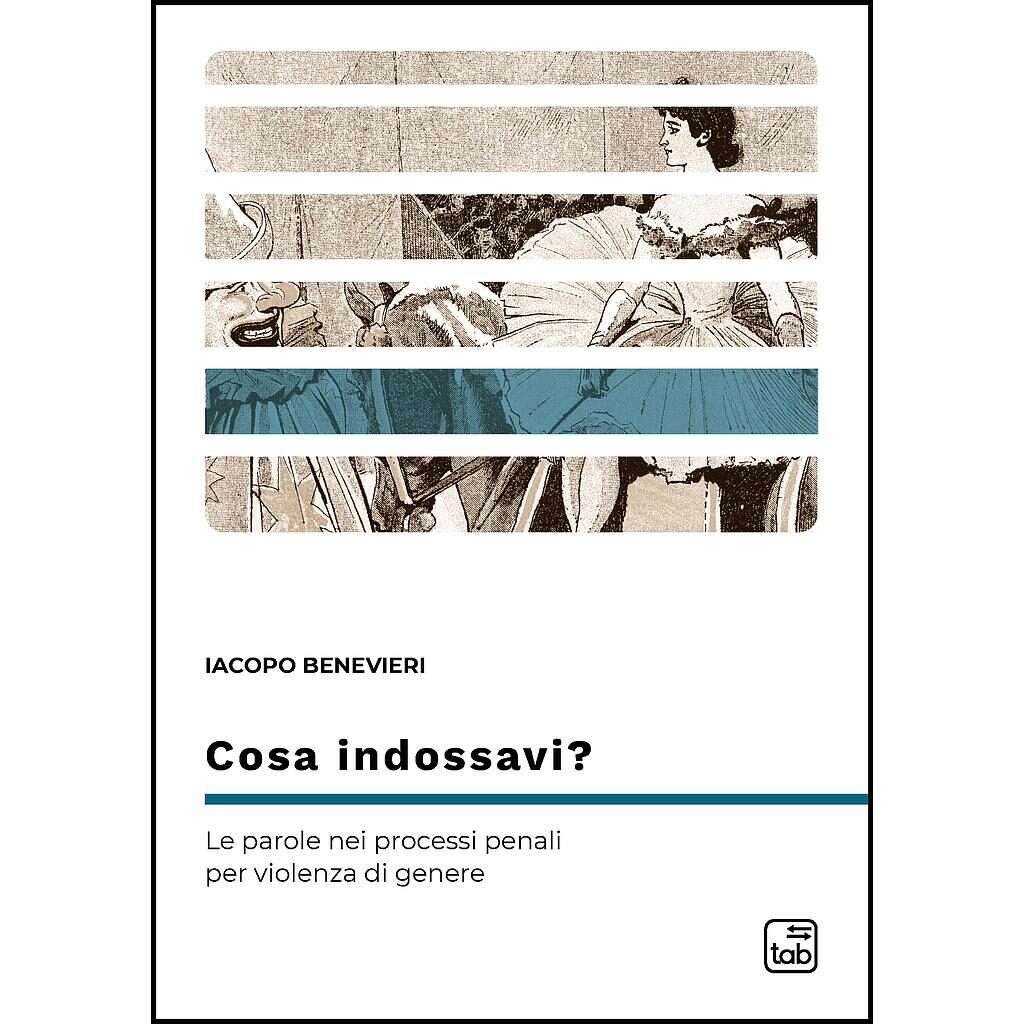
Nel salutarci, Avvocato, ci lascia una piccola citazione di “Cosa indossavi?” – Tab Ed.
"Nel linguaggio si sono incastonate le strutture storiche dell'ordine maschile, travestite da schemi inconsci di percezione e di valutazione. Così 'subire' uno stupro presenta un significante passivo ma conserva anche un profondo significato attivo. E' un verbo socialmente deponente. Oggi come allora e come sempre, nel 'subire' la violenza si scorge la semantica dell'imprudente azione compiuta dalla vittima, piuttosto che quella del torto ricevuto".
Disponibile su Amazon

Direttore di Pink Society
Direttore scientifico di Pianeta Salute 2.0 trasmissione TV, biologa, giornalista pubblicista, avida lettrice, amante del cinema e delle maratone TV, ha l’animo della viaggiatrice e spera di poter tornare a farlo presto in serenità ♥
